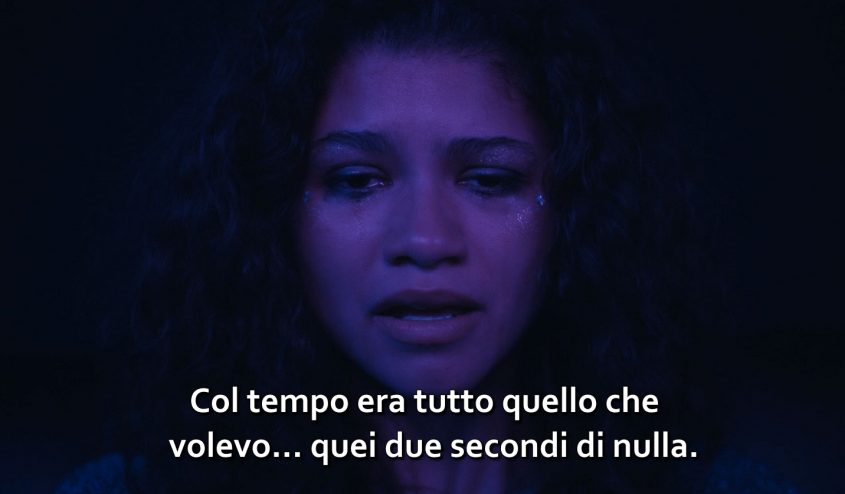Modern Love
Basata sulla celebre rubrica del New York Times, Modern Love racconta l’amore in ogni sua forma. Gli episodi sono brevi, scollegati tra loro, sono come delle pennellate di vita quotidiana. Lo stile è spesso ironico e dolce, l’andamento vivace, gli intrecci mai intrisi di finte romanticherie. Anche se il livello cala un po’ nelle storie centrali, nel complesso scorre che è una meraviglia.